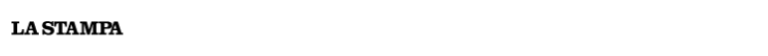
25 novembre 2007
di ENZO BIANCHI
Il percorso di crescita umana e spirituale richiede
La Stampa, 25 novembre 2007
Oggi abbiamo una conoscenza umana, medica e spirituale che pare consentirci di reagire con maggior consapevolezza ed efficacia a quelle “malattie dello spirito” che dai primi secoli del cristianesimo vengono chiamate “vizi capitali”, ma una lettura attenta del messaggio che si cela nel classico elenco delle otto passioni, lo rivela ancora estremamente istruttivo e attuale. Questi “pensieri” che assillano l’essere umano esprimono patologie nei rapporti che l’uomo intrattiene con le dimensioni essenziali della sua vita umana e spirituale: così la gola o ingordigia riguarda il rapporto con il cibo, la lussuria quello con il corpo e la sessualità, l’avarizia il rapporto con le cose, la collera concerne il rapporto con gli altri, la tristezza e l’acedia quelli con il tempo e lo spazio, la vanagloria tocca il rapporto con il fare e, infine, l’orgoglio riguarda il rapporto con Dio. E’ l’essere umano nella sua interezza che è in gioco, proprio nella qualità dei rapporti con la realtà a lui esterna, nei diversi ambiti della sua esistenza.
Ora, perché la passione designata con il termine gastrimarghía, “follia del ventre” e conosciuta dalla tradizione occidentale come “gola”, è la prima della lista? Il racconto biblico di Adamo ed Eva conferma quanto ci dice la nostra esperienza, cioè che ogni vizio umano si innesta sul livello del bisogno primario per eccellenza, quello del nutrimento: occorre mangiare per vivere. Ma l’ingordigia non indica né il naturale soddisfacimento di questo bisogno, né il piacere nel mangiare o il gusto per la bontà dei cibi; no, l’ingordigia è un atteggiamento di smoderatezza in rapporto al cibo, una “brama di cibo non ordinata” che si articola poi in golosità, cioè eccesso nella ricerca della qualità del cibo, e in voracità, incapacità a rispettare tempi e modi nel mangiare. Sì, mangiare è una funzione essenziale, ma rischia sempre di ridursi a un’animalità irriflessa, non ragionata.
Ora, se è vero che noi oggi diamo poca importanza alla voracità, lo è altrettanto il dato che, mai come oggi, sperimentiamo quanto essa sia dannosa per la nostra salute. È paradossale eppure reale: siamo disposti ad accettare i disagi provenienti dagli abusi nel nostro rapporto con il cibo più che non quelli causati da un suo retto uso, cioè le moderate rinunce e la sobrietà che ci consentirebbero di intrattenere un sano rapporto con il nostro corpo. Come non ricordare che la nostra società, mal disposta verso queste “lotte spirituali”, in realtà reintroduce quasi le stesse discipline raccomandate dalla tradizione cristiana – cioè esercizi, digiuni, diete –, per ragioni dietetiche ed estetiche? Nel contesto culturale della nostra “società dei consumi”, dove il cibo non manca mai, l’ingordigia si declina proprio come un vizio di consumo: si tende a ingurgitare cibo alla stregua di carburante per il funzionamento della nostra macchina-corpo, e questa patologia del nutrimento è banalmente giustificata con la mancanza di tempo e l’esigenza di produrre. Non a caso questo imbarbarimento nei rapporti con il cibo ha investito anche l’ambito della preparazione degli alimenti e della sua assunzione: sono scomparse le dimensioni quasi rituali del far da mangiare, cioè del curare la trasfigurazione del cibo da crudo a cotto, e dello “stare” a tavola: oggi si cucina il meno possibile, si mangia velocemente, in piedi, con le mani, guardando la televisione...
E questo nonostante ci rendiamo conto noi stessi di come l’ingordigia ci renda pesanti in senso proprio e figurato: subito dopo un pasto smodato siamo presi da intontimento, da un torpore che offusca l’intelligenza e la lucidità; oppure, e sovente le due cose vanno insieme, avvertiamo sfrenatezza, eccitazione, perdita dei freni inibitori alla lingua, ai gesti, allo stare in mezzo agli altri...
Qui possiamo cogliere meglio l’intuizione patristica dell’ingordigia quale “porta di tutte le passioni”, una porta che si spalanca proprio in quel luogo che è manifestazione del nostro rapporto con il cibo, la tavola: luogo destinato alla condivisione, allo scambio della parola, all’effusione dell’affetto, eccolo trasformato, da un eccesso di cibo e bevande, in focolaio di liti e di violenze, sfogo di ogni aggressività.
Ma sappiamo bene che l’atto del mangiare non ha a che fare solo con il nutrimento fisico, ma appartiene al registro del desiderio e riveste importanti connotazioni affettive e simboliche: il mangiare è atto primordiale e riconoscimento iniziale del mondo; è un rinvio all’attività culturale dell’uomo; è la possibilità di dire che si ama e che si accetta di essere amati. Lo testimonia l’esperienza originaria del neonato, che lo porta a relazionarsi al mondo esterno succhiando il latte, cibandosi cioè della sua stessa madre. Il neonato cerca il seno materno con desiderio prepotente e quasi insaziabile, fino a non distinguere tra la matrice e la persona della madre: vorrebbe divorare questa matrice, avere tutta per sé questa fonte e termine di ogni suo desiderio e bisogno. E noi oggi siamo consapevoli che esperienze traumatiche vissute dal bambino nelle sue relazioni con la madre, soprattutto nella fase dell’allattamento e dello svezzamento, rischiano di causare fissazioni o regressioni a comportamenti infantili, allo “stadio orale”.
Ora, proprio quelle frustrazioni orali che segnano in profondità il nostro inconscio possono generare fami divoranti o altrettanto divoranti astensioni dal cibo. È nel rapporto con il cibo, infatti, che si cercano soluzioni al proprio malessere, con conseguenze mortifere: bisogno di ingurgitare grandi quanti quantità di cibo o di bevande, fino alla bulimia, per soddisfare un’irrefrenabile pulsione orale; oppure, al contrario, rifiuto di ingerire il nutrimento necessario, fino all’anoressia. Prima di essere indice di un malessere spirituale, l’ingordigia si manifesta pertanto come una furiosa perversione del desiderio, che può assumere il volto della psicosi e della nevrosi: che cosa sono infatti bulimia e anoressia se non indici di turbamenti affettivi che si ripercuotono sull’alimentazione?
E così il cibo finisce per sostituirsi all’amore, e il rapporto con esso diventa un mezzo per occultare la sofferenza: l’amore è irraggiungibile, mentre il cibo è a portata di mano… Nella voracità avviene lo stravolgimento del mezzo in fine: il cibo non è più inteso come uno strumento per vivere, per condividere e per festeggiare, ma come una sorta di fine in se stesso! Ecco perché il percorso di crescita umana e spirituale richiede necessariamente la capacità di ordinare tutti i nostri appetiti, a partire da quello fondamentale del cibo. Lì si decide la nostra libertà, lì è il terreno privilegiato per conoscere da cosa siamo abitati.
Enzo Bianchi
Presso la nostra casa editrice sono disponibili i CD:
ENZO BIANCHI
{link_prodotto:id=721}
{link_prodotto:id=726}
{link_prodotto:id=730}
Pubblicato su: La Stampa
